Saggio destinato al libro “La spirtualità della terra” in uscita per Edizioni Colibrì
Qualche prima riflessione.
di Ugo Mattei
Nella tradizione occidentale, (cui sono limitate queste riflessioni) la nozione giuridica di bene riflette la dicotomia cartesiana fra soggetto ed oggetto. Il bene è parte della res extensa, un oggetto che può essere in proprietà di un soggetto, la res cogitans, che lo domina (il dominus latino, colui che esercita il dominio). Nulla c’è dunque di più ontologicamente materiale di un bene, cui la proprietà garantisce un valore d’uso per chi lo possiede, ma sopratutto un valore di scambio per chi lo trasferisce, abusandone nella terminologia del diritto romano. Il valore d’ uso e quello di scambio di un determinato oggetto (bene o cosa sono grosso modo sinonimi giuridici) possono essere concentrati nelle mani di un determinato soggetto, il proprietario privato, che incamera così profitti e rendite. Su questa ontologia cartesiana si fonda la modernità giuridica e su di essa in un rapporto di circolarità, l’ accumulo capitalistico. Il diritto formalizza una porzione del mondo rendendola ontologicamente un bene nella misura in cui esso può essere posseduto da un proprietario. Il diritto oggettifica indipendentemente dalla natura fisica del bene (anche un umano in schiavitù è un bene e così oggi un primate di proprietà di un circo o un suino in proprietà del macellaio) e consente sulla base di questa oggettificazione al capitale di accumularsi a seguito di una catena di scambi produttivi di plusvalore. Una tale analisi del fenomeno giuridico si discosta da quella classica marxiana del diritto come sovrastruttura dei rapporti di produzione sostituendovi una circolarità. Il diritto struttura la produzione capitalistica e si adatta alle forze del capitalismo trasformandosi progressivamente per favorirne il dispiegarsi, in un processo circolare di accumulo e di privatizzazione/mercificazione senza fine.
Questo quadro di senso non è comprensibile al di fuori della costruzione dello stato borghese che porta a pieno compimento la centralizzazione del potere normativo rivendicando il monopolio sulla forza e autoproclamandosi signore della fonte (del diritto). Anche lo stato borghese, persona giuridica per antonomasia, viene costruito dal diritto sia nella dimensione soggettiva (il sovrano) che oggettiva (il territorio) che anche in questo caso è “a disposizione” cioè in proprietà del sovrano. I giuristi parlano di demanio pubblico per distinguerlo dal dominio privato. Tuttavia la logica e la struttura sono le medesime. Una res cogitans che domina una res extensa.
Nell’ ideario della modernità, è difficile immaginare una idea più “materiale” o “materialista” rispetto a quella di un bene. Il bene è identificato con la roba di Verghiana memoria. Il proprietario è Zi Dima Licasi, gretto e schiavo degli imperativi dell’accumulo. Vale la pena di enfatizzare che tanto il demanio quanto il dominio si fondano su due imperativi, la concentrazione del potere e l’esclusione. Si noti che la semplice aggiunta di una collettività di individui come proprietari o di una comunità come sovrana (la comunità di terra e di sangue descritta da Tonnies) non è sufficiente a scardinare questi presupposti. Il condominio negli edifici (come le famigerate assemblee in cui i condomini litigano alla morte) e la comunità inventata, chiusa escludente e razzista (e.g. Padania) esemplificano ciò che ho in mente.
La rivoluzione dei beni comuni, ciò che li rende tanto sovversivi del tranquillo ordine borghese e nello stesso tempo tanto iustituenti di un nuovo ordine, non si limita a una dimensione strutturale o materiale. In questo senso possiamo parlare di spiritualità immanente dei beni comuni.
Occorre soffermarsi brevemente su questa idea. Infatti, molto spesso, e ancora di recente nelle due encicliche ultime di Papa Francesco, torna l’ idea del “bene comune”, una nozione per nulla nuova se non calata nel contesto ecologico (nel senso di sistemico) che costituisce il brodo di coltura del magistero papale. E’ infatti ben noto che l’ idea del “bene comune” al singolare ha profonde radici storiche nella costruzione di un potere trascendente e pastorale. Il bene comune, aristotelico, ripreso dalla patristica e dalla tomistica e’ appunto nozione trascendente che nega il conflitto, presuppone in Dio un assoluto che “riduce ad unita’” il gregge umano essendo, per così dire, nell’ interesse di tutti. Ora questa nozione, quale che ne sia l’ archeologia, si sgancia dai bisogni materiali specifici (del ricco e del povero) sopprime il conflitto sociale ed immagina una intera umanità redenta nel Dio universale e nella Chiesa, appunto, cattolica. In realtà, è sufficiente la prima lettura degli Atti degli Apostoli che la liturgia propone ai credenti nella domenica in albis , per vedere come esista una dimensione del mettere in comune i beni che fonda la comunità degli apostoli nella rinuncia (forse addirittura ripudio) alla proprietà privata individualistica. Una comunità talmente in conflitto col contesto dominante (resistente l’ ordine costituito) da raccogliersi a porte chiuse in una postura di arroccamento e difesa, all’ origine della controffensiva che, in tempi brevi, porterà il cristianesimo al trionfo globale. L’ambizione del pontificato a costituirsi in dominus mundi, ne produce lo snaturamento proprio rispetto al rapporto con la proprietà privata e col potere temporale. In questo passaggio storico e spirituale, i beni comuni originatisi nel ripudio della proprietà privata si trasformano in bene comune trascendente, oppio dei popoli, volto a far accettare come inevitabile lo status quo del mondo in cambio di promessa di vita eterna o di una vaga rivincita nel regno dei cieli (E’ più facile che un cammello passi dalla cruna di un ago che un ricco acceda al regno dei cieli).
Con la riforma protestante anche questa vaga condanna della diseguaglianza terrena cade. E’ vero che Lutero e Calvino si scagliano contro la gerarchia cattolica, opulenta, simoniaca e concubinaria, ma certo, come ben noto, non lo fanno nell’interesse degli ultimi. Al contrario, la riforma protestante accelera la secolarizzazione e il superamento delle posizioni benicomuniste della chiesa di Roma. Si pensi alla condanna dell’usura e al ripudio del reddito da capitale, propri del cristianesimo medievale e fondati su un passo del vangelo di Luca (Lc 6,34). Questo radicale rifiuto evangelico all’accumulazione capitalista e al prestito a interesse termina con la predicazione di Lutero e Calvino. Proprio con la Riforma nascono le equazioni, stradominanti oggi in tempo di neoliberismo spettacolare, fra ricchezza e virtù nonché quella correlata fra povertà e abiezione. Ciascuno è fabbro della propria fortuna insegnano le scuole neoliberali ai futuri uomini a una dimensione!
Nel diritto la riforma produce, con il trasferimento della leadership intellettuale da Salamanca a Leida, l’abbandono definitivo di ogni dottrina della giustizia distributiva (ancora presente nella seconda scolastica) a favore di quella commutativa, che fonda l’evoluzione del diritto dei contratti a meccanismo di produzione generalizzata di valore di scambio. Ovviamente, ciò non poteva che fondarsi su una teoria individualistica ed assolutistica della proprietà privata, che verrà sperimentata principalmente nell’ America del nord dove le teorie Lockeiane della tabula rasa e della terra nullius diverranno prassi genocida di accumulo primitivo.
I beni comuni, grandi sconfitti dell’accumulo primitivo tanto nell’Inghilterra delle enclosures quanto nelle Americhe del genocidio, sono obliterati proprio perché portatori di una dimensione spirituale immanente. Si pensi alla pacha mama, la spiritualità della terra, il culto degli avi sepoliti, la terra in prestito dalle generazioni future alle presenti, o la tradizione biblica del giubileo (iubilaeum), in cui le terre venivano redistribuite e i debiti cancellati (Levitico 25:10-13). Questa dimensione profondamente spirituale, resistente alla quantificazione materialistica e legata viceversa ad una visione qualitativa del mondo (e anche della scienza) fungeva infatti da limite all’ accumulo legando indissolubilmente la ricchezza alla povertà.
E’ questo un passaggio cruciale che merita di essere ribadito per cogliere appieno la portata del cambio di paradigma, per ora in gran parte teorico, portato avanti dal magistero di papa Bergoglio. In un quadro di risorse finite, infatti, e’ evidente che chi consuma di piu’ lo fa a spese dirette di chi non lo potra’ piu’ fare. Se a tavola ci sono cinque carciofi per cinque commensali, se uno ne consuma due lascera’ un altro senza carciofo. La proprieta’ in piu’ dell’ uno genera la non-proprieta’ dell’ altro. Questa banale osservazione mostra la ragione dell’ accanimento con cui, fuori da ogni logica, economisti, uomini politici e imprenditori fanno delle “crescita” il loro vitello d’ oro e ignorano, deridono e financo combattono chi osserva come in un mondo di risorse finite la crescita non puo’ essere infinita. Immaginare infatti la crescita infinita serve infatti a scardinare, a livello planetario, il nesso causale diretto fra ricchezza e poverta’ e la conseguente necessaria critica della piu’ fondamentale fra le istituzioni del capitalismo, ossia la proprieta’ privata accumulabile senza limite, in quanto esito della virtu’ del ricco e non della rapina al povero. Sull’ideologia della crescita infinita si fondano dunque il materialismo, la grettezza e l’ egoismo strutturale alla condizione capitalista che, dall’ enciclica rerum novarum ad oggi la Chiesa romana ha sempre avallato perche’ dominio di Cesare, il cui scettro certo va “temprato” per dirla con Foscolo a proposito di Machiavelli, ma che mai fu indicato come “peccato” in quanto tale finche’ esisteva la minaccia comunista.
Il bene comune nella tradizione della Chiesa cattolica egemonica, proprio come la crescita oggi, sono dunque entita’ trascendenti, falsa coscienza (oppio dei popoli) al servizio dello scettro (ossia il potere concentrato tanto privato quanto pubblico), mentre la prassi benicomunista immanente (abbracciata anche dal Papa), “alle genti svela di che lagrime grondi e di che sangue”.
E’ questo un passaggio chiave, solo in parte celato, per ovvie ragioni tattiche, dal Papa Gesuita. La continua serrata critica alla società dello scarto, la continua rivalutazione spirituale delle culture indigene (portatrici di religioni immanenti), l’ attacco sempre meno mascherato agli imprenditori speculatori, e da ultimo il monito, contenuto in un appello dello scorso novembre, in cui papa Francesco ricorda che “la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata”. Questo posizionamento del pontefice difficilmente può essere mistificato dai riferimenti alla “funzione sociale della proprietà privata” e alla “dottrina sociale” della chiesa, ossia a ideologie che fondamentalmente cercano di salvare il capitalismo da sé stesso.
Il fatto è che la prassi collettiva di cura e di attenzione alle generazioni future, di gratuità e condivisione, quella che Stefano Rodotà, sulle orme di Cassano, chiamava la ragionevole follia dei beni comuni, si fonda sull’ antropologia di un “uomo nuovo” (per dirla con Gramsci), che nulla è se non relazione generativa con gli altri e con la natura, visti come beneficiari (o vittime) dirette dei suoi comportamenti. Chi accumula beni oltre una certa soglia ( e la misura è superata da molti, quasi tutti i decisori autentici dei processi politici) ruba, impoverisce tutti, chi già è seduto alla mensa della casa comune e chi ancora non c’è (perché deve ancora nascere o perché’ altra specie vivente non soggettivizzata). Esiste nel benicomunismo una compenetrazione spirituale immanente con chi ancora non c’è e che quindi, già lo osservava Nietzsche, è più difficile da amare perché non è “prossimo”. In un certo senso, se il prossimo va amato “come te stesso” (secondo insegnamento che risale al Levitico 10, 27) chi non è prossimo perché ha da venire o vive in condizioni geografiche o sociali così lontane da non poter essere neppure immaginato (e quindi riconosciuto come sorella) è amato “più di te stesso” perché curarlo impone un sacrificio qui e adesso per ritorni che mai vedremo.
E allora, la svolta immanente del Papa, dal bene comune ai beni comuni, non può aver paura di condannare la concentrazione del potere “in quanto tale”, che è poi l’ essenza astratta dell’ accumulo in una visione crescitista del mondo. Ciò avviene, pur negli sfarzi degli abiti talari e cardinalizi e di una struttura del diritto canonico che è stata esempio storico ed è ancora prassi giuridica del potere concentrato, in modo molto esplicito nelle due encicliche ultime. Egli presenta come dottrina sociale della chiesa quello che invece, nella piena consapevolezza della devastazione dell’ antropocene, non può che coerentemente divenire un ritorno a quel comunismo originario, abbandonato poco dopo la seconda visita agli apostoli, in presenza di Tommaso, per le mutate condizioni materiali della predicazione e successivamente per amor di potere. Una prospettiva egalitaria che, tuttavia, attraversa in maniera episodica tutta la storia della chiesa, dai movimenti pauperisti del medioevo ai gesuiti martiri anticapitalisti dell’America Latina.
Ma la scelta benicomunista immanente, se condotta in modo coerente, impone anche a Francesco alcune scelte di campo, che vanno dalla preferenza per istituzioni mendicanti o in forma pauperis , all’abbraccio senza se e senza ma alla teologia della liberazione, alla critica serrata a dinamiche capitalistiche oscene (estrazione di valore dal terrore tramite la deportazione digitale e l’imposizione della sperimentazione farmaceutica a vantaggio dei grandi gruppi di capitale globale), al superamento di rituali barbari non più giustificati come l’olocausto degli agnelli pasquali.
Non solo chi proviene dalla tradizione trascendente può arricchire la propria spiritualità tramite la prassi di cura, ma anche quanti, come chi scrive, provengono dal materialismo dialettico occidentale, possono arricchire il senso della propria esistenza percependo appieno la dimensione spirituale che la preoccupazione per le generazioni future necessariamente genera.
E’ infatti la cooperazione intergenerazionale in quanto tale lega fra loro esperienze politiche profondamente diverse, in un fronte ampio volto ad emancipare la base nei confronti delle soperchierie perpetrate, in modo strutturale, dai vertici, dalle gerarchie, dalle oligarchie. Chi agisce oggi pensando al “non prossimo” da un lato limita la propria dimensione dell’ avere materiale ( e del conseguente autismo consumistico), ma dall’ altra amplifica largamente la dimensione dell’ essere, cioè la libertà autentica. Le generazioni future hanno bisogno di noi per venire al mondo, ma noi abbiamo bisogno di loro per dar senso al nostro stare al mondo. Questa indicazione condanna il capitalismo estrattivo e ne sostituisce gli imperativi materialistici di accumulo con imperativi di condivisione, solidarietà e ricostruzione del collettivo, che ripudiamo le contrapposizioni pre-politiche artatamente celate dallo spettacolo del potere, per perpetuarsi nella solita vecchia cantilena del divide et impera.
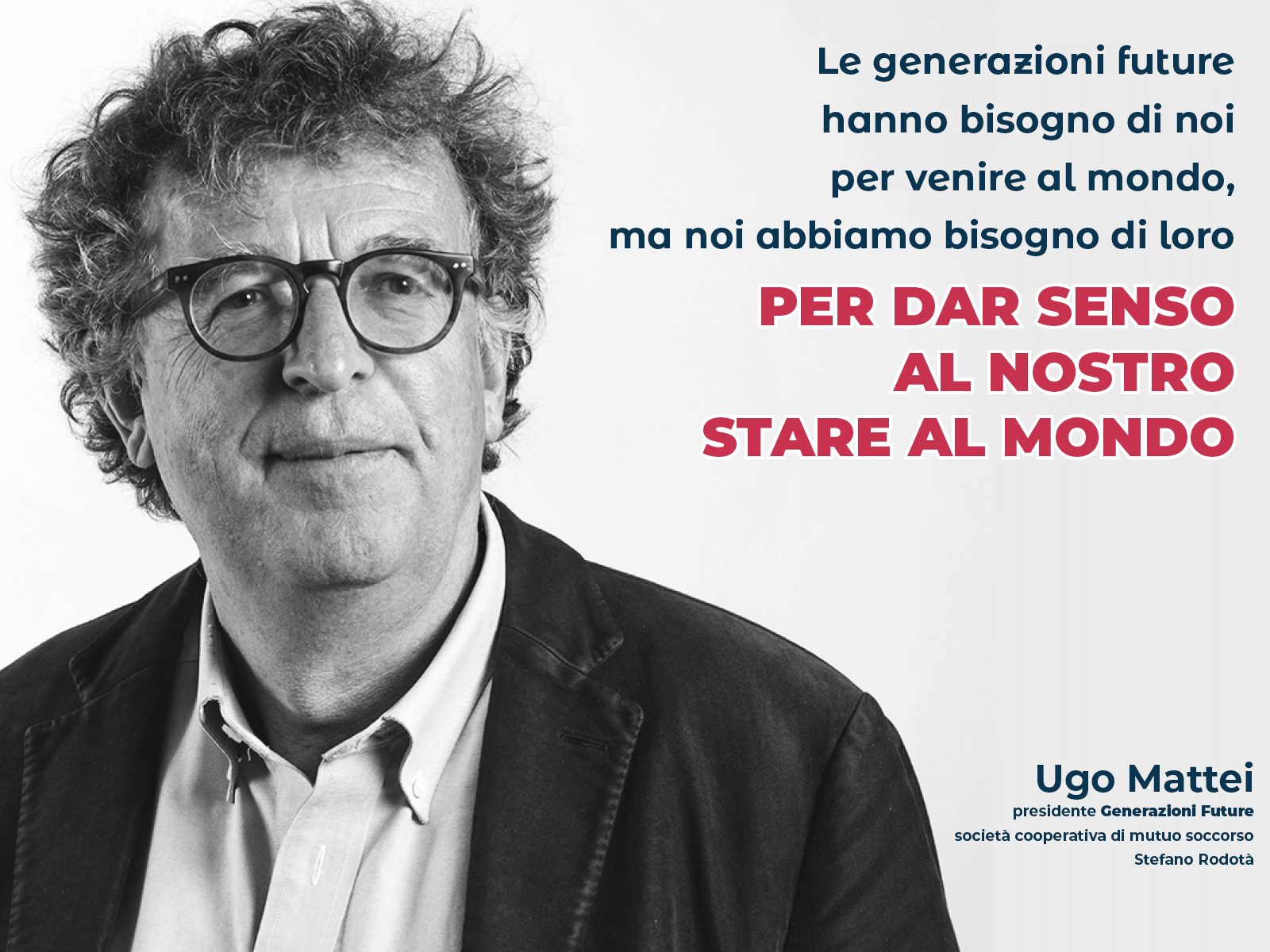



Si ma non dobbiamo commettere sempre lo stesso errore di non lavorare prima dentro di noi ,cercare l’uno, vedere le nostre parti d’ombra, si rischia se no di non centrare mai la vera realtà ,ma solo un risolvere problemi che alla fine non portano a nessun risultato concreto ,la storia è piena di questi eventi finito in in nulla di fatto ,il Comunismo ne è stato anch’esso vittima concentratoi soltanto a livello politico ,senza vedere l’essere, l esistenziale dell’essere
Concordo con Andrea, aggiungo che conoscere se stessi è un percorso solitario dove l’individuo prende in mano non solo se stesso ma la responsabilità che ne consegue. Gruppi, movimenti, maestri, istruttori, guru, filosofie, teosofie, tecniche, riti, meditazioni, simboli sono solo stampelle, indubbiamente utili, ma non sono la soluzione o il percorso vero e proprio. La ripetizione di qualsiasi cosa porta alla strutturazione della stessa e alla perdita del suo stesso valore, essere creativi significa essere sempre diversi in un abbraccio che raccoglie ogni aspetto. Per questo motivo se invece di guardare alle differenze si guardasse ai punti comuni si potrebbe costruire qualcosa, non tanto come gruppo quanto a livello personale: la personale verità del mio vicino, compresa nel suo contesto e storia, può solo arricchirmi. Questo è un mondo fatto di scelte e responsabilità, solo ciò che costruiamo dentro ci porteremo via.